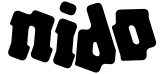Matteo Parmigiani
La sindrome del boschetto
ANNO 01 | NUMERO 06 | APR 2023
Due giorni dopo aver discusso la tesi di laurea cominciai a cercare lavoro.
«Aspetta,» dicevano amici e parenti. «Ti sei appena laureato, goditela un po’. Te la sei meritata la vacanza!»
«Non sono in vacanza» rispondevo io. «Sono disoccupato. È diverso.»
Proprio non volevano capire.
Navigavo tra i motori di ricerca e mi candidavo alle offerte. All’inizio le leggevo attentamente e selezionavo quelle più “in linea” (così mi avevano detto di fare) col mio profilo. Ma dopo un’ora mi ero già rotto le palle e avevo preso a mandare cv a raffica. Aprivo e spedivo.
La maggior parte delle offerte era come commerciale. Cercavano gente disposta a vendere aspirapolveri, assicurazioni, pannelli fotovoltaici… Cazzo, pensavo, non ho mica speso tutto quel tempo sui libri per poi ridurmi a telefonare a casalinghe depresse e proporre stronzate simili. Ma dov’erano finiti i bei vecchi lavori? Dove si nascondevano?
Poco dopo ero passato alle offerte di lavoro come consulente, salvo poi scoprire che è solo un modo più fighetto con cui chiamare i commerciali.
Aprivo e inviavo. Avanti così.
Le chiamate arrivarono dopo circa una settimana.
«Buongiorno, abbiamo ricevuto il suo curriculum. Sarebbe disponibile per un colloquio? E quando?» Erano per lo più donne e ripetevano tutte la stessa litania.
Il primo colloquio che mi venne fissato era, tanto per cambiare, come commerciale in un’azienda che fabbricava tubi. Appuntamento per le undici del mattino.
Arrivai che erano le undici e dieci e mi fecero fare quasi quaranta minuti d’anticamera. «Sbrigo una cosa e sono subito da lei» m’aveva detto la ragazzina delle risorse umane prima di sparire. Una nana con due fondi di bottiglia al posto degli occhiali e un cespuglio di rovi scuri in testa.
Si ripresentò proprio mentre stavo per alzarmi e andarmene. «S’accomodi» disse.
La seguii in una stanza con due grandi vetrate che davano su viale Vittor Pisani. «Bella vista» dissi indicando la Stazione Centrale in fondo.
«Eh, sì»
M’ero ripromesso che, almeno al primo colloquio, avrei cercato d’essere carino. Così le strinsi la mano.
«Prego.» Indicò la sedia davanti a lei.
Ci sedemmo.
«Allora» iniziò. «Io sono Laura, l’HR director.»
«Piacere. È la prima volta che ho a che fare con un HR director.»
«Bene. Allora cominciamo…»
«Sì, cominciamo» ripetei come un coglione. Dovevo averla interrotta perché vidi che si stizzì.
«Sì… ho visto il suo curriculum.» Lo tirò fuori e lo posò sul tavolo. «Noi cerchiamo un giovane da formare, disponibile a crescere in una realtà stimolante. Questa è un’azienda che fattura più di quattro milioni e mezzo all’anno. Abbiamo tre sedi e centocinquanta dipendenti.»
Parlava come se l’azienda fosse sua.
«Lei è disponibile a lavorare in team e su turni flessibili?»
«Sì… beh, io… giocavo a calcetto.»
Restò in silenzio per un istante. «Ne sono felice» disse poi sarcastica.
Altra stronzata. Non ricordo chi mi aveva detto, tempo prima, che guardavano cose di quel tipo quando dovevano scegliere gente da mettere in un team.
«L’inglese?» domandò.
«Buono.»
«Solo buono?»
«Devo parlare con inglesi?»
«Le nostre sedi sono in Italia.»
«Allora a cosa serve l’inglese?»
Alzò gli occhi al cielo. «Oggi non saper l’inglese è un handicap molto forte.»
Iniziava a starmi sul cazzo.
«Attitudini?»
«In che senso?»
«Le sue attitudini, quali sono?»
Mi grattai la fronte cercando di capire cosa volesse.
«Senta, io ho bisogno di gente motivata, rapida.» Schioccò le dita. «Sveglia. Ha capito? Gente veloce.»
Cominciai a sentire uno strano prurito sul dorso della mano destra. Poi sulla sinistra. Mi grattai strofinandole.
Lei mi guardò e poi riprese: «Non assumo uno che non sa bene cosa vuole fare nella vita…»
Questa un cazzo non l’ha mai visto neanche disegnato, pensai.
«…non ho tempo da perdere io. L’azienda fattura più di…»
Era abbastanza. «Chissà quante cose avrà da fare lei che fa l’eichar» sbottai.
«Sì. L’HR, esatto.»
«Potrei parlare col direttore?» Questa scena l’avevo vista fare in un film di poliziotti alcune sere prima, sapevo l’avrebbe mandata in bestia.
«Come?»
«Il direttore, il capo vero. Quello che sta sopra di lei e che decide veramente.»
Sospirò. «Sono io la direttrice del personale.»
«Ok, capito. La lascio al suo importantissimo lavoro di lettura cv e passacarte.» Mi alzai.
«Ma scusi!»
«Non si disturbi» la bloccai, «a dirmi che mi farete sapere. Tanto so che non mi farete sapere niente.»
Uscii e mi diressi all’Hob’s, il pub sotto casa. Passavo lì quasi tutte le sere. Lungo la strada mi fermai da un tabaccaio. Comprai cinquanta gratta e vinci. Volevo sfidare la statistica, vincere un sacco di soldi e togliermi il problema del lavoro. Spesi centoventicinque euro. Il prurito intanto aumentava. Raggiunsi il bancone del pub, ordinai una birra e cominciai a grattare.
Non vinsi un euro. Quello che aveva teorizzato la statistica doveva essere lo stesso figlio di puttana che ha inventato i gratta e vinci. Pagai e tornai a casa.
La mattina dopo notai che mi erano comparse alcune macchioline gialle. Ci strofinai sopra il sapone e ripresi a mandare cv.
Il secondo colloquio lo feci per un’azienda di vestiario, posizione di sales representative, cioè il commerciale, ma detto in inglese.
Questa volta l’HR era un maschio. Presi posto e mi presentai.
Mi lasciò parlare per qualche minuto del più e del meno poi mi puntò l’indice e disse: «Skills?»
«Eh?»
«Ho cercato, lei non ha Linkedin.»
«No.»
«Perché?»
«Non saprei, io…»
«Senza Linkedin è fuori dal mondo.»
«Fuori dal mondo?» sorrisi. «Addirittura.»
Mi guardò le mani. Le piaghe stavano diventando veri e propri bubboni verdognoli. «Ma cos’ha?»
Le nascosi sotto al tavolo.
Un’espressione schifata gli attraversò il viso.
«Cosa volete propormi allora?» cambiai argomento.
«Cerchiamo una persona motivata.»
«Sveglia e dinamica?»
«Esatto» annuì.
Questi eichar sono bambocci fatti in serie, pensai.
Mi fece una raffica di domande su come passavo il tempo, gli hobby e le aspirazioni. Come mi vedevo da lì a cinque anni e stronzate del genere. Poi ci congedammo. Disse che mi avrebbe fatto sapere e quando gli porsi la mano mi puntò gli occhi addosso. «Va bene così.»
Sulla strada verso casa notai che intorno ai bubboni si stavano creando delle crosticine gialle. Ne grattai una e mi fece un male cane. Sangue secco misto a pus bianco colarono lungo il polso sporcando la manica della camicia.
Andai spedito in farmacia. «Avrei bisogno di una pomata.»
«Per cosa?»
Alzai le braccia mostrandogli i dorsi delle mani.
«Oh, Gesù! Ma cos’ha fatto?»
«Dev’esserci un’epidemia di peste.»
«Faccia vedere.»
Mi avvicinai e gli piazzai lo schifo davanti agli occhi. «Di cosa si tratta?»
«Non ne ho la minima idea. Deve farsi visitare da un medico. Potrebbe servire una cura di antibiotici.»
«Non ha qualcosa da darmi?»
Si voltò e frugò per dieci minuti buoni tra gli scaffali. «Ecco» mi porse un tubetto bianco.
«Sulfadiazina?» lessi ad alta voce. Era una pomata per le ustioni gravi.
«Ne spalmi un bel po’, e vada da un medico, mi raccomando!»
«Grazie.»
«Venticinque euro, prego.»
Tornai a casa e mi impiastricciai con l’unguento. Sembrava calcestruzzo. Durante la notte mi svegliai più volte. La pelle in fiamme. Forse è perché fa effetto, pensai. La mattina seguente i bubboni erano aumentati e avevano cambiato colore. Uno schifo. Erano verde scuro circondati da una corona rossa.
Dato che non avevo colloqui andai di filato dal medico. Passai quasi due ore in sala d’attesa, tra vecchi che tossivano e rantolavano. Li guardavo in silenzio, abbassavo gli occhi sulle mie mani malconce e poi tornavo a fissarli.
Quando fu il mio turno entrai e mi sedetti.
«Cos’ha?» mi domandò il dottore. Era un uomo sulla sessantina, ma ne dimostrava almeno quindici in più. Faccia e capelli grigi e respiro da fumatore incallito.
«Dobbiamo amputare» sorrisi e gli mostrai quel vomito.
«Mm…» Si grattò il mento. «Interessante.»
Mi fece accomodare sul lettino e scartò un ago sterile. «Qua la mano.»
Sentii l’acciaio freddo bucare la crosta e infilarsi nella cupola di carne marcia. «Ahia» urlai. «No, no. Cazzo che male.»
«Sembrano quasi delle cisti sebacee…»
Liberai la mia mano dalle sue grinfie.
Mi allungò del cotone per tamponare e tornò alla scrivania. Rimase al computer per un bel po’. A battere sulla tastiera.
«Quindi?»
Scosse la testa. «Deve andare da un dermatologo. Intanto le posso dare un unguento per pulire le infezioni.» Scarabocchiò qualcosa e mi diede la ricetta. «E metta delle garze.»
Tornai dal farmacista.
«Ecco il nostro appestato. Passata bene la notte?»
Gli diedi la ricetta senza parlare.
Lesse e scosse la testa. «Bah… sarà!»
«Cosa?»
«Gliel’ha detto il medico?»
«No, il tabaccaio.»
«Lei si crede spiritoso, vero?» Tornò a frugare sul suo scaffale parlottando tra sé. Poi mi diede la confezione.
«Catalasi equina? È uno scherzo?»
«Per questo sono perplesso. Comunque sono ventidue euro e cinquanta.»
«Ha delle garze?»
Mentre tornavo ricevetti una telefonata. Era per un colloquio e non da commerciale, un call center. Ci accordammo per il giorno seguente, di prima mattina. Mi sedetti su una panchina, srotolai le garze e fasciai le ferite fino ai polsi. Poi andai diretto all’Hob’s. Avevo bisogno di bere qualcosa per tirarmi su. Finita la birra media, proprio mentre stavo per pagare, mi si sedette di fianco una ragazza. Era un po’ su d’età rispetto a me. Avrà avuto sui trentacinque. Però non era male. Le sorrisi.
«Ciao» disse. «Stai andando?»
«No, io…» ripresi posto al bancone. «Birra?»
«Grazie!»
Bevemmo due medie a testa e ne ordinai una terza. Ero disoccupato e non avevo molti soldi ma la prospettiva di portarmela a casa era di gran lunga la cosa più interessante che mi capitava da tempo.
«Cos’hai alle mani?» chiese indicando le fasciature.
«Niente, un piccolo infortunio.»
«Sembri Padre Pio.»
Ridemmo. L’alcol si faceva sentire. Finito il terzo giro mi lanciai. «Senti, ma… dov’è che abiti?»
Lei intanto continuava a ridere.
La fissai aspettando una risposta che non arrivava.
«Io sto in un appartamento minuscolo in fondo…»
«Ah, ecco il mio ragazzo!»
Il tipo ci raggiunse e mi lanciò un’occhiataccia. Sarà stato alto uno e novanta, ben piazzato. Si voltò verso di lei e limonarono per qualche minuto.
«Scusa, stavi dicendo?» mi domandò poi la ragazza tra le risate.
«Niente, stavo andando.» Non le avevo neanche chiesto il nome. Lasciai il posto all’energumeno e uscii.
Per strada la testa cominciò a vorticare. Avevo bevuto troppo.
Raggiunsi l’appartamento e mi buttai a letto coi vestiti addosso. Dormii male, il mio stomaco ingaggiò per tutta la notte un combattimento all’ultimo sangue con i fermenti della birra artigianale.
Mi svegliai sudato, con la nausea e le tempie che martellavano. Infilai la porta senza lavarmi e cambiarmi. Riuscii non so come ad arrancare fino al colloquio. Il call center era in zona Porta Venezia, non lontano. Arrivai anche puntuale.
Il responsabile, un tipo grassottello e coi capelli pieni di gel, mi accolse e ci mettemmo in uno stanzino. «Lei?» chiese con voce nasale.
«Sono qui per l’offerta di lavoro.»
«Si sente bene?»
Dovevo avere la faccia tra il bianco e il giallo smorto. «Sì.» Parlare era davvero faticoso.
«Cerchiamo persone da adibire all’assistenza clienti. Il contratto dura tre mesi, rinnovabile.»
«Va bene.»
«Com’è che si chiama?»
Capii in quel momento che il mio cv non l’avevano neanche guardato. Poi la situazione precipitò. Il mio stomaco aveva perso la battaglia. «Mi scusi.» Uscii con passo svelto e fuori dal palazzo mi diressi nel parco vicino. Raggiunsi il bidone dell’immondizia e ci vomitai dentro. Gli occhi si inumidirono e la testa sembrava voler scoppiare.
«Maestra, maestra. Guarda!» sentii urlare.
Alzai lo sguardo e vidi una scolaresca, saranno stati di prima, massimo seconda elementare. Mi fissavano immobili. «Bambini, forza!» li richiamò l’insegnante.
Mi lasciai cadere su una panchina. Ero esausto. Poco distante c’era un piccolo pony sul quale i ragazzini potevano salire a turno e farsi fotografare. Lo osservai. Anche lui mi guardò. Ruminava. In quel momento provai il desiderio di piangere. Era tutto così faticoso.
Tornai a casa e dormii per il resto della mattinata. Rimasi rintanato in appartamento per quattro giorni. Ogni sera spalmavo la crema e cambiavo le garze ma le pustole non volevano saperne di sparire. Intanto avevo smesso di mandare cv e non rispondevo al telefono.
Riuscii a contattare un dermatologo e andai nel suo studio il lunedì seguente. Mi ricevette subito.
«Come va?» Era uno di quei tipi capaci metterti a tuo agio in pochi istanti.
Gli raccontai tutto, prese un dermatoscopio e si mise a studiare le pustole da vicino. «Ma guarda un po’» commentava. «Era da un sacco che non vedevo niente di simile.»
«È grave?»
«Sembrerebbe una dermatoelosi bacili eczemica.»
«Ah. Quindi? È grave?»
«O forse… una polimorfia seborroico maculosa nodosum.»
«Eh? Ma è grave?»
«O magari… un lichenoides purpurica et pigmentosa. Sì, probabile.»
«Senta!»
Alzò la testa e tornò a guardarmi.
«Mi dice cosa succede?»
«Uno sfogo cutaneo.»
«Tutto qui?»
«Cosa credeva d’avere? Una desquamazione? Una psoriasi? Un cancro? Un…»
«Va bene, va bene. Mi dica cosa fare, almeno la finiamo.»
«Nulla. Non deve fare proprio nulla.»
Ero indeciso se mandarlo a fanculo o inginocchiarmi e baciargli i piedi.
«Vede, si tratta di semplice “sindrome da boschetto”.»
«Sarebbe a dire?»
«Uno sfogo che avviene dopo periodi di particolare stress o forti delusioni. Viene ai manager che lavorano troppo o ai militari tornati dal fronte» mi spiegò compiaciuto.
«Quindi dovrei sentirmi lusingato?»
«Ah, ah. No. È detta “boschetto” per via del colore verde platano che le pustole assumono nel periodo…»
«Ho capito!»
«Deve lasciar perdere tutto quello che sta facendo e prendersi un mese di totale relax.»
«Veramente non sto facendo niente. Sono disoccupato.»
«Lasci perdere la ricerca di lavoro. Non è più un disoccupato, adesso è un convalescente.»
Mi sentii subito meglio.
«Se ne freghi. Si goda la primavera, faccia passeggiate.»
«Lo farò, grazie dottore» risposi rasserenato. Qualcosa dentro di me si sciolse e un sentimento di leggerezza mi avvolse. Quell’uomo era il mio salvatore e non l’avrei dimenticato.
Mi alzi e mi avviai pieno di speranza verso l’uscita. Lo guardai un’ultima volta e sorrisi. Lui ricambiò. Poi afferrai la maniglia.
«Ah, mi scusi» mi richiamò.
«Mi dica?» tornai da lui con il sole nel viso.
«Sono duecentoquarantaquattro euro.» Strizzò l’occhio. «Oppure duecento tondi, senza fattura.»
Aprile 2023