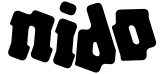Giovanna Cirnigliaro
Virus
ANNO 01 | NUMERO 07 | MAG 2023
IL CASCO
Ricordo perfettamente l’ultima volta che ho incrociato lo sguardo di qualcuno. Non mi capitava da tempo, non ricordo quanto. Forse c’entrava quel mio casco difettoso… le poche volte che durante una passeggiata scorgevo qualcuno, non appena vedeva il mio casco retrò e un po’ ammaccato girava alla larga, spaventato, a volte infastidito, nel peggiore dei casi inorridito. Ma sinceramente non mi andava di cambiarlo. Normalmente lo odiavo, eppure all’idea di darlo dentro per avere in cambio uno dei nuovi modelli dai colori fluorescenti o dai gadget inutili ma che ormai sembravano indispensabili (tipo gli auricolari, la cannuccia o il cristallo antipioggia incorporati), mi rendevo conto che un po’ ci ero affezionata. Era uno dei primi modelli usciti, quando il dpcm 180 li aveva resi obbligatori, da tenere addosso h 24. Era trasparente, dalle linee semplici, poco invasivo, pur coprendo il volto integralmente. Pensavo che non mi ci sarei mai abituata a tenere quel coso in testa. “Piuttosto crepo, ma respirando senza scafandro” dicevo a me stessa. Poi in qualche modo mi ero arresa. Sarà stata la solita pressione sociale? O mio padre che ci teneva troppo che io tenessi alla mia vita ancora un po’? O la mia stessa paura di morire? In parte si, ma a posteriori credo ci fosse sempre stata in me anche la recondita speranza che qualcosa, non so cosa, potesse ancora accadere e il free solo universale non avrebbe inghiottito anche la mia seppur misera esistenza. In tanti si erano rifiutati di mettere il casco, rifiuto che corrispondeva inesorabilmente al contagio e alla morte. Fu letteralmente un suicidio di massa. E prendere il virus senza assistenza medica a quell’epoca voleva dire soffocare lentamente, in giorni e giorni, e soffrire lo sfibrarsi delle membra e dell’anima in piena coscienza di sé, fino a raggiungere l’exitus agonizzando come un verme solitario. Capitava di vedere corpi contorti ed emaciati come rami secchi ai lati delle strade, raramente corpi embricati, forse di persone che avevano provato a donarsi l’un l’altra letteralmente fino all’ultimo respiro… un estremo esempio di folie a deux, dicevano gli esperti. Poi a un certo punto di quei corpi non se ne videro più. Forse perché spirati coloro che abbracciavano il suicidio eroico, rimasero quelli del suicidio tecnico. Più razionali e al passo coi tempi, si recavano alle Case di buona morte, così hanno ribattezzato gli ex ospedali, dove i medici, non potendo più salvare vite, sono diventati i professionisti della morte, quella cosiddetta “sostenibile”. Di funerali ovviamente non ne facevano più. Si moriva sempre soli. Ma questo era il meno. “Risparmiamo sulle pompe funebri” si diceva. Oltre al fatto che si evitavano quei dialoghi strazianti o posticci coi pochi parenti superstiti. Di amici tanto non ce n’erano più.
IL VOLANTINO
All’inizio, quando non si era ancora totalmente disillusi rispetto all’efficacia del vaccino, avevo fatto qualche tentativo, poi risultato tragico, per trovare qualcosa per cui valesse la pena sopportare tutto questo. Credo che fossi inconsciamente convinta che l’unica possibilità fosse di tornare a vivere in qualche modo come prima.
L’esperimento di cui mi sono vergognata di più è stato l’ultimo, da quel momento in poi mi è mancato il coraggio di prendere qualsiasi altra iniziativa. Pensavo davvero che qualcuno avrebbe preso dalle mie mani inguantate uno stupido volantino? Nessuno arrivò a leggerne neanche il titolo, che pure avevo scritto bello grosso e in una forma che mi sembrava un pizzico accattivante “Nuovo antivirus: condividere per vivere”. Poi il testo non lo ricordo più, anche se ci avevo lavorato per diversi giorni, come un vecchio artista preso improvvisamente dalla nostalgia e dalla smania di creare. Avevo scelto di distribuirlo in piazza Duomo, perché in teoria era il posto più affollato, ma in pratica c’erano appena quattro gatti. Una signora anziana appoggiata a un bastone, un senza tetto seduto su un cartone, un uomo deforme che strisciava per entrare nella piazza in quel momento e un signore normale. Il signore normale è stato il primo che ho provato ad approcciare col mio volantino tremante in mano, ma prontamente è corso via appena ha capito che l’avevo puntato. Cosa che avrebbe fatto anche la vecchia, se solo avesse potuto correre. Appoggiata al suo bastone si muoveva lenta e ansante, lo si capiva dal casco appannato, aveva paura anche lei? Le dissi qualche parola gentile per tranquillizzarla ma quando le fui a un metro si voltò e mi prese letteralmente a bastonate imprecandomi contro e accusandomi come fossi un’assassina “Non volevo morire io, carogna! Volevo solo vedere il cielo, vattene! Morirò per colpa tua maledetta…”. Il senza tetto intanto mi fissava ridacchiando dentro al suo casco sudicio. Nel tempo in cui la vecchia si dileguava, lui attaccò a parlare “Te la sei cercata però! Fidati, stai alla larga da qui. Ecco, non ho un bastone per cacciarti” ridacchiò isterico e vischioso. “Ma mi son guadagnato questo spazio spartendolo con lo storpio e non voglio altre rogne. Il tuo papiro lascialo lì se ci tieni tanto, non so leggere ma so come usarlo” e indicò un tombino bagnato a pochi metri di distanza, da dove provenivano fetore e virulenza. Volevo solo che tacesse, ma lui continuò, bofonchiando: “Evidentemente non conosci lo storpio, il primo grande successo del vaccino numero uno! Sul corpo vedi gli effetti collaterali, dentro ha tutto l’odio del mondo. Se non ti ammazzi da sola cercando contatti random, lui ti aiuta volentieri…”
LA PANCHINA
Il vaccino, infatti, non aveva funzionato. Le varianti ora erano migliaia. Io ero stanca.
Almeno mi ero adattata in qualche modo nel mio monolocale. Perché ormai sì, esistevano solo monolocali. Avevano abbattuto tutti gli appartamenti e gli edifici fuori norma per costruire questi alveari di cemento costituiti da tanti piccoli loculi porzione singola. Stavo tranquilla nel mio monolocale, appunto, quando lessi l’annuncio: “Se qualcuno volesse augurarmi buona morte di persona sarò domani a mezzogiorno sulla prima panchina all’ingresso del parco delle cave”. Augurare buona morte? Di persona? Cosa sta dicendo questo? Chi farebbe una cosa del genere?
Forse io.
Ci andai.
E c’era pure qualcun’altro. Non tante persone, ma devo dire neanche poche. Di sicuro molte più di quelle che mi aspettavo. Sinceramente non mi capitava di vedere così tante persone nello stesso posto da anni. Soprattutto non erano lì per caso. Tanto che guardavano tutti nello stesso punto. La panchina. Lì c’era un ragazzo seduto e immobile, portava un bel casco turchese all’ultimo grido.
Uno ad uno i presenti si avvicinavano, per modo di dire, a non più di tre metri dalla panchina. “Buona morte” dicevano, e si allontanavano, come una specie di processione senza candele, senza fiori, senza bandiere, senza vita. Sentivo bene, anche se ero lontana, quel malsano augurio bisbigliato che riempiva il silenzio già di per sé inquietante.
Mi avvicinai anch’io ed è lì che ho incrociato quell’ultimo sguardo, come ricevere una scossa rivitalizzante e allo stesso tempo devastante. Quello che successe lì lo ricordo come fosse stato ieri.
-Buona vita! Dissi
-Quale vita?
-La tua…
-E che vita è la mia?
-Non lo so, penso non tanto diversa dalla mia.
-E che vita è la tua?
-Triste. Vuota.
-E sarebbe una vita buona?
-No. Ma mi rifiuto di augurarti buona morte come gli altri.
-Perché? Se ci toglie da questa vita non è buona, la morte?
-Ci sarà qualcos’altro che ci tolga da questa vita…
-Ah, quindi anche tu te ne vuoi andare?
-Non saprei dove andarmene, più che altro io voglio la vita che c’era prima.
-E cosa c’era prima? Io non mi ricordo molto.
-C’era tutto, c’era! C’era il bar sempre aperto sotto casa, c’erano le vacanze al mare o il cenone di Natale, c’era il lavoro poi il sabato sera con gli amici, c’era lo stare a casa con qualcuno quando fuori piove e hai la tristezza nel cuore…
-Che sono gli amici?
-Ma tu non sai niente! Ti faccio io una domanda: quanti anni hai?
-14.
-Pochissimi… quanti di incubatrice?
-10.
Un’infinità, ho pensato, ma non l’ho detto. Quando i caschi erano diventati obbligatori, si era posto il problema dei neonati: come mettere loro quel casco? Gli esperti collaudarono delle incubatrici apposta per tutti i nascituri da lì in avanti. Peccato che per evitare il contatto tra genitori e figli, le incubatrici erano state programmate per provvedere a tutto: allattare, cullare, scaldare, dare da mangiare, tenere per mano ai primi passi… finché il bambino non sarebbe stato in grado di procurarsi l’essenziale da solo. Non so quante madri e quanti padri si ribellarono a questo stupro della genitorialità. Ma il dpcm era ferreo. In tanti finirono in carcere, altrettanti alle Case di buona morte… in pochi anni più nessuno fece figli. Anche perché il dpcm successivo vietò qualsiasi tipo di convivenza e impose il trasferimento nei monolocali.
Eppure, questo ragazzo era nato, ed era figlio di qualcuno. Anche se aveva trascorso in incubatrice 10 anni.
Non riuscii a continuare in questo flusso di coscienza perché intanto i suoi occhi mi penetravano più dei pensieri.
-E tu quanti anni di incubatrice?
-Io… nessuno, sono vecchia, non esistevano le incubatrici quando sono nata io…
-E come hai fatto a diventare grande senza incubatrice?
-Con i miei genitori…
Ti prego non chiedermi cosa sono i genitori, pensai, ma ovviamente lo fece. Gli raccontai dei miei, delle mie sorelle, dei miei amici… ogni cosa che descrivevo gli faceva nascere un’altra domanda. Intanto, senza accorgermene, mi ero seduta di fianco a lui sulla panchina mentre gli raccontavo concitata di tutto ciò che c’era prima. Lui d’un tratto si fece cupo:
– Scusami, dovresti stare più lontana… Se malauguratamente io ti contagiassi sarebbe un peccato perché tu non te ne vuoi andare… Se tu invece malauguratamente contagiassi me non avrebbe importanza perché io tra poco me ne vado.
-Non andartene.
-Ormai ho fatto il mio bilancio. E tutto quello che mi racconti mi fa pensare che ho fatto la scelta giusta. Non ho mai vissuto quello che hai vissuto tu. Tu hai la memoria di tante cose a farti compagnia. Io non ho niente.
-Ma perché non te ne sei andato e basta? Perché quell’annuncio assurdo?
Abbassò lo sguardo piano, sembrava cercare qualche parola che non trovava. Poi rispose.
-Qualche tempo fa per terra ho trovato una cosa strana. Ero piccolo e inesperto del mondo, l’ho raccolta. Era un foglio scritto e parlava del condividere… ma invitava a farlo di persona, non virtualmente… da allora ho iniziato a stare male, a volte non respiravo bene anche se il casco era a posto… ho pensato avessi preso il virus, ma non morivo! E mi era venuta quella strana voglia di condividere per vivere, ma non sapevo cosa… Adesso però ce l’ho fatta, quel foglio forse diceva qualcosa di vero!
Mi lanciò uno sguardo lucido, si alzò di scatto dalla panchina e corse via nel prato davanti a noi.
Lo seguii sopraffatta, ma solo con lo sguardo.
All’improvviso tolse il casco celeste e lo lanciò distante mentre continuava a correre.
Maggio 2023