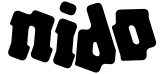Rosalia Messina
Mimì
ANNO 01 | NUMERO 12 | OTT 2023
La prima volta che la notai era uno di quei giorni in cui l’inverno si attarda, sconfinando nelle prime settimane di marzo. Nelle ore intorno all’alba in città era caduta una spolverata di neve. I fiocchi si scioglievano appena toccavano terra, ma sui social arrivarono decine di foto scattate sull’Appennino: e lì di neve ce n’era un bel po’.
Lei era imbacuccata in un cappotto pesante verde scuro; un berretto di lana grossa color senape le scendeva sulla fronte fino a coprirle le sopracciglia e una sciarpa a righe grigie e nere le si avvolgeva più volte intorno al collo magro. Tutto ciò che indossava sembrava più grande della sua taglia. Anche gli stivaletti in cui sprofondavano le caviglie esili davano l’idea di essere troppo grandi.
Qualcosa di indefinito mi fece pensare di averla già incontrata. Ma dove? Una donna di mezza età, piccola e piuttosto povera, a giudicare dagli abiti modesti e di sicuro vecchi, forse appartenuti ad altri prima che a lei: cosa potevamo avere in comune? Non riuscii a trovare tracce nella memoria, ma la sensazione permaneva.
Lei stava appartata: non incrociava il mio sguardo, non si accorgeva di nessuno. Quando arrivò l’autobus si scosse e salì senza affrettarsi.
Le lasciai l’ultimo sedile rimasto libero, indicandoglielo con un gesto. Le sorrisi. Solo allora mi guardò, sollevando il visetto triangolare da bambina invecchiata verso la sommità del mio metro e ottantotto. Ricambiò il sorriso, con un guizzo indecifrabile, forse di sorpresa.
Arrivò la mia fermata. La salutai, lei rispose. Di nuovo mi sembrò che la mia attenzione in qualche modo la colpisse.
Nei giorni seguenti la rividi allo stesso posto, alla stessa ora. Scambiare un saluto divenne un’abitudine. Certe volte Mimì, come fra me e me l’avevo battezzata, non era lì nel suo cappottone triste, con quel faccino stanco e remoto. Ma di solito c’era.
In quel periodo la mia inclinazione per le dipendenze aveva assunto una forma particolare. Non sapevo fino a quando sarebbe durata: non sono mai stato in grado di prevedere per quanto tempo le mie stranezze, come le chiamo quando ne parlo con la mia analista, mi faranno compagnia. Ossessioni, così preferisce chiamarle la dottoressa Barbieri, sessantenne in forma, occhi freddi e voce calda, pazienza e capacità di ascolto infinite. Si sono presentate per la prima volta intorno ai nove anni e nel tempo hanno assunto varie forme, sempre meno innocue via via che crescevo: collezioni di oggetti insoliti; incetta di giochi elettronici molto costosi che potevo procurarmi solo saccheggiando il borsellino di mia madre e quello di mia nonna, che mai diedero segno di essersene accorte; consumo eccessivo di certi cibi, poi di certe sostanze, poi di certi farmaci; acquisto compulsivo di capi d’abbigliamento alla moda; gioco d’azzardo; tatuaggi. Così come arrivava, la stranezza (o l’ossessione) se ne andava di colpo, di solito dopo alcuni mesi, a volte dopo qualche settimana.
«Un andamento non facile da comprendere» commenta serafica la dottoressa Barbieri. Prende appunti, mi lascia parlare, mi ricorda alla fine delle sedute che posso telefonarle quando voglio. Mi sembra che anche questa terapia sia a suo modo una dipendenza, forse la più duratura. Mi riprometto ogni volta di chiederglielo, ma finisco per dimenticarmene.
Nonostante le mie stranezze sono cresciuto. Sono piuttosto solitario, non manca di osservare mia madre, che non è al corrente delle mie relazioni amorose, troppo effimere perché si arrivi alla presentazione in famiglia. Per l’amicizia non ho tempo.
Mi sono laureato in Ingegneria informatica, ho trovato un lavoro discreto in un’azienda solida, da tre anni abito per conto mio in un monolocale in affitto e progetto di addentrarmi nell’avventura del mutuo e dell’acquisto di una casa. Ho sempre pagato con puntualità le sedute di psicoterapia, iniziate appena sono diventato economicamente indipendente; da un po’ sono finite le rate mensili della Renault Clio.
L’ossessione che coltivavo più o meno un anno fa, quando incrociai Mimì alla fermata dell’autobus, stride con questo quadretto rassicurante come una brutta cravatta di tessuto scadente su un abito di buon taglio.
Per una settimana circa Mimì non si fece vedere. Poi ricomparve, ancora più ammaccata del solito. Scambiammo il consueto cenno di saluto.
Il suo sedile, quel giorno, era due file più indietro del mio, dal lato opposto. Girandomi di tre quarti potevo vederla con la coda dell’occhio. Lei guardava fuori dal finestrino.
Avevo scelto la mia vittima. La distanza era quella giusta. L’ometto magro, anziano, dal colorito giallastro, le spalle curve, sembrava perso nei suoi pensieri o forse assonnato. Il portafogli che gonfiava la tasca posteriore dei pantaloni blu stazzonati era a portata delle mie dita lunghe e agili. Da pianista, dicono spesso le donne. Quasi tutti, intorno a noi, erano concentrati sui loro cellulari; una suora, davanti a me, dormicchiava appoggiata al finestrino; due ragazzini sui tredici anni, con gli zaini sulle spalle, scherzavano in modo rumoroso, ridendo di qualche sciocchezza nota soltanto a loro.
Le mie mani iniziarono il loro viaggio verso la tasca del candidato al borseggio di quella mattina. C’ero quasi, quando un colpo di tosse mi fece girare il capo verso Mimì. Incontrai il suo sguardo inespressivo fisso nel mio. Nessuno dei due distolse gli occhi, le mie mani si fermarono e tornarono a posto, con lentezza. Aspettai qualche istante prima di alzarmi e di avanzare senza fretta verso la porta. Prima di scendere mi voltai e la salutai con un cenno del capo. Mi fece ciao con la mano.
Non avevo bisogno di denaro: non era per quello che sfidavo ogni giorno la sorte. Ero pochissimo interessato al contenuto di portafogli e borsellini. Spendevo i soldi rubati senza rimorsi, ma non so cosa mi spingesse a rubarli. Non riesco a decifrare le mie stranezze. Neppure la dottoressa Barbieri ha trovato finora spiegazioni soddisfacenti, ma non si arrende.
Per un mese andai al lavoro con la Renault. Il giorno in cui mi avventurai a riprendere l’autobus, Mimì non c’era. Non la incontrai più.
La mia ossessione era passata, sostituita da un’innocua passione per i film di fantascienza. Mi abbonai a moltissime piattaforme per vederli in streaming e per un periodo la mia già scarsa vita sociale si azzerò: sfruttavo ogni momento libero per immergermi nelle storie di mondi lontani. Vidi Interstellar decine di volte, come pure Solaris. Blade Runner mi entusiasmò meno, mi fermai a quattro visioni.
È trascorso del tempo ‒ dev’essere poco più di un anno ‒ dal giorno in cui Mimì mi impedì di derubare l’ennesimo malcapitato, ponendo fine a una luminosa carriera di borseggiatore.
Una settimana fa, mentre passavo davanti a una sala giochi che frequentavo anni addietro, ai tempi dell’ossessione dell’azzardo, la vidi. Era ferma davanti alle porte scorrevoli, stretta nel cappottone che indossava nonostante l’aria primaverile. Fumava una sigaretta e guardava nel vuoto.
Di colpo mi venne in mente che c’eravamo incontrati lì. Non avevamo scambiato neppure una parola o un saluto: ai tempi in cui frequentavo quel posto triste non badavo a chi mi stava intorno. Sono luoghi di incontro fra solitudini che si ignorano a vicenda. Mi spiegai l’aria sorpresa che le si era dipinta sul faccino triangolare la prima volta che si era accorta di me sull’autobus: la sua fisionomia mi ricordava qualcosa di vago, mentre lei mi aveva proprio riconosciuto.
Alzò la mano nel saluto infantile che le avevo visto fare il mio ultimo giorno da borseggiatore dilettante.
«Giochi di nuovo qui?» mi chiese, con una voce rauca e sottile che assomigliava al suo aspetto minuto e stropicciato.
Scossi la testa e le tesi la mano.
«Matteo» mi presentai.
«Rachele.»
«Buona fortuna» fu l’unica cosa che riuscii a dirle. Non vedevo l’ora di andar via, di allontanare l’idea che anche lei si dedicasse al borseggio. Forse era così che si procurava il denaro da dilapidare al gioco. Non volevo sapere nulla, non volevo pormi domande.
«Anche a te» mormorò, abbassando lo sguardo.
Chissà se la incrocerò ancora sui sentieri delle mie ossessioni.
Per ora ho scoperto la cucina. Trascorro ogni momento libero a provare nuove ricette. A volte invento.
«Tutti hanno qualche hobby» commenta la dottoressa Barbieri. «Il suo problema è la modalità ossessiva. Lo spazio che lei dà alle sue attività, come dire, ludiche, ecco, non è equilibrato, va a discapito della sua vita sociale, delle relazioni. Ma poi mangia tutti i piatti che prepara? Sembra di no, la sua linea non mi pare cambiata.»
«Rendo felici madre, nonna, colleghi, vicini di casa. Io assaggio piccole quantità, poi riempio dei contenitori e li distribuisco.»
«Mi includa nella lista di distribuzione!» esclama ridendo. «E si tenga sempre lontano dai passatempi contrari al codice penale» aggiunge con un sospiro, tornando seria.
Sospiro pure io.
«Dottoressa, credo di non sentire più la necessità di questi colloqui. Penso di dover convivere con le mie ossessioni, tanto non sono riuscito a liberarmene, solo a sostituirne una con un’altra. Come faccio da tutta la vita.»
«Se restiamo sul terreno delle attività innocue, sono d’accordo. Io, comunque, sono sempre qui se lei sentisse il bisogno di parlarne.»
Annuisco, pensando: non credo.
Ho realizzato che posso impiegare l’ora settimanale di terapia con ciò che mi appassiona. Non vedo l’ora di uscire da questo studio di legno chiaro, tappezzerie sobrie e cristalli per raggiungere la mia cucina piccola ma superattrezzata e di riprovare la ricetta del Mont Blanc, che l’altra volta mi è sembrato discreto ma potrebbe riuscirmi meglio.
Ottobre 2023