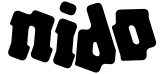Serena Barsottelli
Run, Baby, Run
ANNO 02 | NUMERO 14 | DIC 2023
Dimostrava almeno diciotto anni, per questo diceva di averne diciannove. In realtà erano sedici neanche compiuti. Quando sorrideva, il viso le si crepava in due frammenti; era divisa tra ciò che era dentro e ciò che era fuori come il giorno e la notte. Le due metà si incontravano come aurora e crepuscolo, poi tornavano a ignorarsi. Per Luisa non era proprio così: nascondeva la parte che riteneva più fragile, come l’urna del nonno sul ripiano più in alto della credenza in salotto. A tutti mostrava quello che si aspettavano di vedere, e intanto un po’ di lei moriva.
Morire come giorno, come notte.
A piedi nudi, sulle punte, sotto le punte, il pavimento freddo. La pelle prima illuminata e poi celata nel passaggio dal corridoio alla camera in penombra. Abituata ad abbracciare il buio, Luisa indugiò nell’oscurità della felpa che scivolava lungo le braccia e che le spettinava i capelli. Fu cieca per qualche istante, e ogni suono sembrò lontano. Se si fosse rannicchiata a terra, pensò, avrebbe creduto di essere nel grembo materno. O in trappola dentro a una bolla. Sarebbe scoppiata? Come la rabbia, come la testa in cui gli stessi pensieri si accalcavano. Era solo questione di tempo, e poi avrebbe liberato tutto. Giù, nello scarico del cesso. Luisa sarebbe stata leggera e vuota.
Poi fu luce. Poi fu rumore. Come alba, come vita. Un pianto interno, un sorriso esterno.
Su una trapunta primaverile fiorita di papaveri, l’aspettava il tubino nero. lo indossò lasciando scivolare le mani sul cotone; a dispetto del movimento, il suo giudizio fu poco delicato e indulgente: le segnava i fianchi, ancora. Sospirò sedendosi sul bordo del letto e infilò un piede dopo l’altro in calze color carne, invisibili a uno sguardo distratto. Invisibili, presenti: l’avrebbero riparata dal freddo e da un contatto non richiesto. La canzone del momento – che cambiava, pur sembrando sempre la stessa, srotolando parole che non era sempre in grado di fermare – le luci ora violente ora soffici; corpi, tanti corpi, aggrovigliati, così vicini da confondere i confini, e mani indiscrete che scivolavano troppo in basso o troppo in alto.
Venti denari al costo di pochi spiccioli.
Una camicia leggera, di pizzo. La pelle ora nuda, ora coperta. Avrebbe dovuto rinfrescare il trucco e fermare i capelli con undici forcine. La dodicesima nel portamonete.
Occhi neri, la matita sbaffata sotto le ciglia inferiori, ché se avesse pianto nessuno avrebbe fatto caso allo scempio. Il dolore può avere tante maschere, eppure ci si aspetta di vedere sempre la stessa. Se li vedeva davanti, anche se non c’erano: avrebbe voluto parlare con loro, con tutti quelli che giudicavano senza sapere. Quelli che credevano che lei fosse troppo. Aggiungevano “sicura di sé”. Provavano ad afferrarla, ma non sarebbero mai arrivati alla sua anima: l’aveva buttata giù premendo il bottone dello sciacquone. Giù, nel cesso. La forma di quello che aveva perduto era quella della cena. Era più semplice credere che si potesse morire di fame anziché di indifferenza.
Liberazione, tormento.
Quando vomitava chiudeva le palpebre: in quel buio non c’erano immagini, perché le figure, come le forme delle nuvole, sono per i sognatori. E se qualcuno si fosse addentrato in quella oscurità, se qualcuno avesse provato ad accarezzarla, lei si sarebbe ritratta come una vergine la notte delle nozze, e poi avrebbe iniziato a sanguinare.
Sangue. Rossetto.
Per il rossetto c’era tempo: doveva ancora finire di liberarsi. Non sarebbe rimasto niente, dentro. Accese lo stereo: una voce femminile, calda, graffiando il palato le raccontava la vita.
She was born in November 1963…
E anche se non era tutto vero, non nel suo caso, mentre restava bloccata sul pavimento di ghiaccio, sentì l’impulso di andarsene. Allontanarsi. Chiuse la porta del bagno più piccolo. Per sicurezza fece roteare la chiave di un secondo giro.
Sola. Dentro. Appoggiò al legno l’orecchio per sincerarsi che nessuno fosse lì dietro. Aprì il mobiletto dei medicinali, estrasse un laccio del colore dei capelli e li legò dietro la nuca. Non era piacevole imbrattarli di vomito e acqua del cesso, e questo l’aveva scoperto a proprie spese. Si rannicchiò, le ginocchia scure di lividi. Sulle mani calli e segni involontari di denti. Un dito in bocca non le bastava. Forse due avrebbero compiuto il proprio dovere, ma preferiva andare sul sicuro: ne mise tre.
She smiles the secret smile, and sure she knows exactly how to carry on.
Un suono simile a un rantolo di un animale. Non si liberava mai abbastanza: restavano sempre i succhi gastrici, e con loro, la fastidiosa sensazione di dolore. L’impulso a chinarsi in avanti e la fatica che si provava a rialzarsi.
Vomitare era disgustoso, ma necessario. Un’espiazione per la propria colpa. Il vuoto che si provava dopo doveva esser simile a questo: un ricettario a disposizione, uno stampo nuovo in silicone turchese e la dispensa piena di ingredienti. Un recipiente colmo d’aria e di rabbia.
Le si inumidirono gli occhi e schiacciò le lacrime con il dorso pulito della mano. Provò ad alzarsi: un leggero formicolio sotto il velo delle calze corse dalla punta dei piedi alle cosce.
So run baby, run baby
Run baby, run baby, run.
Facendo forza sulle braccia si trascinò al lavandino. Si sciacquò la bocca, e nel farlo i polsini della camicia si inumidirono appena. La canzone era finita e nel silenzio riusciva a vedere meglio il proprio riflesso nello specchio. Si toccò i capelli, poi li sciolse dal giogo dell’elastico. In quella cornice, il viso era ancora più pallido. Le occhiaie profonde. Avrebbe dovuto coprire tutto con uno strato generoso di fondotinta, ma non lo fece.
Un passo indietro per controllarsi, quel tanto che bastava a mostrarle i fianchi larghi che sembravano uscire dal tessuto. Un informe mostro di grasso ingurgitava ciò che esisteva fino all’attimo precedente. Una vertigine, l’incauta voragine che si apriva dal suo stomaco corroso, e risucchiava quel poco che di lei era rimasto tra i centimetri di corpo contenuti nella sua pelle.
Mosse il bacino in una danza lenta e morta, poi la voragine divenne buio, o forse fu il pavimento a risucchiarla in una buca. Il dolore, per un attimo, si fermò.
«Luisa, hai finito in bagno?»
Appena in tempo.
«Mamma, arrivo subito».
«Non vorrai mica fare tardi? Ti aspettano, lo sai».
Emanuela, Anna, Maria: si strizzavano in una macchina troppo piccola per tutte e cantavano di amori infelici, perché tutti gli amori alla fine sono a senso unico. Erano un bel gruppo, almeno in apparenza, perché in realtà il segreto di Luisa non lo conosceva nessuna di loro. Erano troppo perfette per lasciarsi sporcare dalla sua macchia nera.
«Avete una mentina?» chiese salendo sulla 500 blu di Anna.
«Hai intenzione di limonare con qualcuno, eh!» ironizzò Maria.
Luisa non rispose e nascose i brutti segni sulle dita nella borsa. Poi l’autoradio riprese a trasmettere una canzone leggera. Le voci delle altre riempivano l’abitacolo; Luisa, invece, muoveva solo le labbra senza emettere alcun suono.
Parole, silenzio. Luce, buio. Giorno, notte. Fuori, dentro.
*
Quando non sapeva come giustificarlo, si inventava la scusa di una sigaretta. Aveva iniziato così a fumare, per non ammetterlo. Era diventato così naturale mentire che a volte persino lei non riusciva a distinguere menzogna da verità.
«Ciao! Non vorrei sembrare il solito sfigato, ma…»
La musica alta, sempre uguale, arrivava fino all’esterno del locale. Mentre fissava quel ragazzo, pensò che le parole diventassero incomprensibili quando non erano importanti.
«Cioè, ti ho vista prima, e… Hai un paio di minuti? Cioè, eri lì, al centro della pista, e non sono riuscito a toglierti gli occhi di dosso. Ballavi come se non ci fosse nessun altro intorno a te».
La conosceva, lei, quella sensazione: la fraintendevano tutti.
«Mi prenderai per un maniaco, ma devo dirtelo: sei bellissima».
Nessuno le aveva detto che era un peso; l’aveva capito da sola. Si era barricata dietro un vetro, dentro il forno, lasciando che altri la ammirassero come una torta che imbrunisce. Avevano tutti la presunzione di intuirne la perfetta cottura senza controllare con un bastoncino. Guardavano, credevano.
«Ho visto che muovevi le labbra, che forse cantavi. E poi volevo ascoltare la tua voce. Se non ti avessi parlato, be’, mi sarei mangiato le mani tutta la vita».
Sbagliavano. Tutti fanno errori, e alcuni pesano di più. Un peso, i fianchi troppo larghi, un numero sulla bilancia.
«Forse tutta la vita no, ma sicuramente per il resto della serata e magari anche tutto domani. Insomma, posso sapere come ti chiami?»
Nessuna lettera, solo cifre in un sistema binario. Luce, ombra. Acceso, spento. Un numero: accanto al proprio nome sul registro di scuola; in fila, a comprare il pane e alle poste; in attesa del prelievo di sangue, poi del ritiro del risultato – ma che cosa vuoi avere, tu, sei sana come un pesce!
«Non faccio così con tutte. Insomma, non sono quel tipo di ragazzo che vuole per forza rimorchiare. Ma vorrei conoscerti, sentirti, anche con calma, quando avrai tempo. Mi piacerebbe avere il tuo numero».
Cinquanta, se si riferiva ai chili. Appena sotto il peso forma per il medico; per lei cifre dalla grafia troppo tonda che disegnavano cerchi con il suo corpo; sette virgola venticinque, un modesto sette più, se si accontentava della media a scuola. Quattordici, gli anni in cui aveva perso la verginità con Mannini, il rappresentante d’istituto durante la terza notte dell’occupazione. Sei giorni di silenzio, dopo, senza incontrarlo nei corridoi, neppure cercandolo fuori dall’aula o aspettandolo all’uscita da scuola. Ventidue i giorni di ritardo.
Luce, ombra. Acceso, spento.
«Ho parlato così tanto e non ti ho neanche detto chi sono. Piacere, Edoardo».
Brillavano, forse di entusiasmo, forse di alcol. Forse era la luce della luna che arrivava, nonostante la pensilina che avrebbe dovuto riparare gli avventori in caso di pioggia. Erano belli gli occhi di Edoardo perché sembravano sinceri.
«Piacere», mentì.
Mentre giocherellava con il braccialetto di borchie, pensando a quale nome darsi quella volta, le passarono per la mente quelli che aveva già usato. Per quanto tempo avrebbe continuato così? Strozzandosi, esattamente come quel tubino nero faceva con i suoi fianchi. E se avesse provato a essere sincera? Alzò e abbassò le spalle, scrollandosi di un peso. Le lettere uscirono dalla bocca in un soffio. «Mi chiamo Luisa».
Edoardo strinse la sua mano. «Hai freddo?»
Avrebbe dato la colpa al sudore, all’imbarazzo? All’emozione, così gli altri la chiamavano. Gli altri, non lei, perché l’unica che provava era rivolta a sé; incapace di trattenerla, la riversava come lava su tutto il mondo: silenziosa e inesorabile lasciava un tappeto scuro e sterile su qualsiasi superficie si posasse.
«Andiamo a sederci?»
La guidò su un divanetto poco distante, in un angolo del giardino tranquillo. Lì il frastuono si trasformava in brusio, le voci in sussurri. Le sfiorò il gomito che il pizzo lasciava scoperto, poi la sottile striscia di pelle nera incastonata da punte in acciaio. La baciò, lo lasciò fare. Le farfugliò qualcosa all’orecchio che non le fu subito chiaro. Un complimento, un invito: era solo l’ennesimo inganno. Un uomo inganna sempre una donna, e una donna l’uomo. Quello che non sarebbe riuscita a perdonarsi era la capacità con cui riusciva a mentire anche a sé stessa, davanti allo specchio, sulla bilancia, in mezzo alla pista, a tavola o su un divanetto.
«Quanti anni mi dai?» gli chiese.
«Non si dovrebbe chiedere l’età a una signora» scherzò. «Diciannove? Venti?»
Dolore alla gola e poi al centro del petto. L’aria si era fatta eco tra le pareti vuote del suo corpo.
«Ne ho quindici e la mia cena è tutta nel cesso».
Lo fissò, cercando qualcosa che non riuscì a ritrovare. Eppure, poco prima, le era sembrato di scorgerla. Luisa scosse il capo, mentre gli occhi del ragazzo si rivolgevano altrove. La pregò di aspettarlo, indietreggiando, ché avrebbe preso qualcosa da bere, magari di analcolico. Sarebbe tornato subito subito, giusto il tempo di arrivare al bar interno.
Lo osservò sparire fuori dalla sua visuale. Lo immaginò confondersi tra la folla come non la avesse mai incontrata. Estrasse una sigaretta; la fumò senza aspirare. La brezza della sera era meravigliosa mentre fendeva il suo corpo, la sua pelle seminuda. Il freddo era capace di insinuarsi anche in quei ritagli di tessuto. Cercò di tirare giù le maniche e di riparare i polsi mentre interrogava in silenzio le stelle. Loro sapevano tutto, persino della cena scivolata nello scarico, e dallo scarico nella fogna.
Edoardo non sarebbe tornato.
Le spalle si incurvarono mentre avvicinava le ginocchia al viso.
«Aspetti qualcuno?»
Scorse un volto nascosto da riccioli.
«Nessuno».
I suoi occhi non brillavano, anzi, sembravano tristi.
«Sarebbe un vero peccato lasciarti da sola. Ti dispiace se mi siedo?»
«Fai pure».
Due corpi sospesi come neve e come tempo, bloccati nella distanza.
«Io sono Marco. E tu?»
«Lucia», mentì.
«Vieni qui spesso?»
«Il sabato sera».
«Mica andrai ancora al liceo?», rise lui.
Marco le posò una mano sul ginocchio. Era più vicino, adesso, ma Luisa non riusciva a togliersi di dosso la sensazione di freddo.
«No, figurati. Mi mancano due esami alla laurea».
«Però! Io non sono riuscito ad andare oltre il primo. I voti, quei numeri, non fanno per me. Non so se capisci quello che intendo».
«Temo di no. I numeri sono solo numeri; non hanno importanza».
Novanta sessanta novanta: la bellezza. Tre e dieci si contendevano il podio per il numero perfetto. Al banco della gastronomia era impossibile rispettare la richiesta che veniva fatta. Non bisognava esagerare con il riso: non più di sessanta grammi a pasto.
«I numeri sono solo numeri».
Luisa rabbrividì, poi riprese: «Lo senti anche tu?»
«Cosa?»
«Questo freddo».
I rami della palma davanti a loro erano fermi, così anche le foglie. Era una notte senza brezza.
«Vuoi tornare dentro?», le chiese.
Come gli altri, non poteva capire; avrebbe pensato che fossero per la febbre o perché le calze non le tenevano abbastanza caldo alle gambe. Forse l’avrebbe abbracciata più forte, con la scusa di riscaldarla, tenendola ferma e sempre più in trappola.
Luisa trattenne il respiro mentre estraeva ogni forcina dal ciuffo. Aprì la borsetta e le ripose con cura. Un maglioncino di cotone le si posò sulle spalle.
«Te lo presto, se vuoi».
Non era il gelo. Era la voglia di correre, senza meta. Libera dal peso che qualcuno fosse ad aspettarti al traguardo. Senza un predatore alle spalle. Sola, in una prateria al sorgere del sole. O su una spiaggia, al tramonto, mentre la superficie dell’acqua si tingeva di fuoco.
«Grazie».
«Ti accompagno dentro, se vuoi».
Dal locale arrivavano note senza senso, come le parole scappate dalla bocca di Marco. Luisa sospirò, e poi senza accorgersene iniziò a fischiettare quella canzone che aveva ascoltato poco prima, a casa, mentre si torturava.
So run baby, run baby
Run baby, run baby, run.
I piedi incollati alle scarpe, le scarpe alle suole, le suole alla terra.
Dicembre 2023