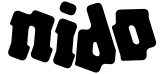Simona Rampini
Presunta gioia
ANNO 02 | NUMERO 17 | MAR 2024
Entra nella stanza come una sposa vestita di bianco, accompagnato da sette paggi, tutti avvolti dalla luce della sapienza di Ippocrate, che lo seguono con le cartelline portafogli e le biro per annotare ogni sua più piccola esternazione.
«E questa, da quanto è qui?»
«Da ieri sera, Professore.»
«Segni di travaglio?»
«Nessuno, ma sono sicuro che stanotte…»
«Macché! Ho bisogno dei letti. Induciamo, induciamo.»
Lancia il bouquet e passa alla prossima fortunata, un fruscio di camici fa largo al suo incedere da primario.
Che significa induciamo, eh? Parla con me cazzo! Sono qui, mi vedi? Son quella con la pancia come un gigantesco cocomero.
Niente, neppure buonasera. Sono così gonfia di stanchezza, liquidi e mesi, che non riesco ad allacciarmi le scarpe, ma per quella testa di cazzo sono invisibile.
E non è l’unico, prima di lui c’è stato il ginecologo del pronto soccorso.
«Credo si siano rotte le acque» dico sdraiata sul lettino.
Lui ci riflette un attimo, poi alza un sopracciglio: «Non si sarà fatta un po’ di pipì addosso?».
Lo incenerisco con uno sguardo mentre penso che sia un vero coglione. Sto per aprire la bocca e scandire la parola, quando l’infermiera mi precede.
«Ma cosa dice, dottore! Una donna è capace di distinguere le due cose, sa?»
Non si convince, neppure di fronte al documento che certifica che ho abbondantemente superato il termine della gravidanza, lo stesso che ha compilato un suo collega due giorni prima. Vuole le prove.
L’infermiera fa il test e glielo sbatte sul tavolo uscendo: arruolata. Salgo in degenza che sono le undici di sera.
Mi sistemano in una stanza accanto alle sale parto. Ho una compagna sofferente in pieno travaglio, ansima, soffia, si lamenta, resta con me qualche ora poi la dilatazione è sufficiente e la spostano in sala. Altre donne si lamentano, piangono, si sentono vagiti e urla, mi torna in mente Dante e mi dico che per scrivere l’Inferno deve aver fatto un salto nel girone delle puerpere. Non riesco a prendere sonno, mi infilo le cuffiette e cerco un album che mi rilassi, ma la musica che ho scelto non è sufficiente a coprire i gemiti: fanculo, mi sparo in cuffia tutto Californication dei Red Hot.
Guardo il tracciato delle mie contrazioni: è attivo ma fermo e il mio utero muto. Invece le puerpere si avvicendano, con occhi allucinati, scarmigliate, sudate, piegate su sé stesse dalle doglie, ma io non le sento più. Nei libri sulla maternità, quelli dalle copertine rosa e le immagini di bambini biondi sorridenti, con occhi enormi celesti, dovrebbero inserire un disclaimer per tutelarsi di fronte alla delusione inflitta alle donne come me, quelle che non rientrano nei parametri da manuale.
Respiro un’ansia densa, zuppa di paura e coraggio insieme. Penso che questo sia davvero il momento in cui l’essere umano è spogliato di ogni costrutto sociale, è nudo di fronte alla potenza del primordiale. Non c’è più alcuna barriera di razza e cultura, siamo tutte giovenche gravide assoggettate dalla violenza della nascita. Trattate come tali: c’è bisogno del letto, sotto la prossima.
E così mi attaccano a una flebo di ossitocina e in meno di mezz’ora stringo i denti per le contrazioni: fitte acute mi tolgono il fiato, la pancia si indurisce e si accartoccia, stritolata da una forza aliena che non appartiene certo ai miei addominali, che forse non si vedono più, ma sotto sono flaccidi. L’intervallo tra una contrazione e l’altra è serrato, così per tre lunghissime ore, quando senza alcun ritegno sbraito per avere l’epidurale. Non ottengo risposta, chiedo nuovamente, ho firmato giorni fa per questa eventualità, non la potete negare, cazzo!
Finalmente si palesa l’infermiere che, scocciato, va a chiamare l’anestesista, non prima di aver bofonchiato: «Quante storie… partoriscono tutte, sa?».
Il punto è, lui, che ne sa?
La tregua chimica è una manna, mi adagio nel letto e sento Fabio che mi asciuga la fronte, indossa le cuffiette per isolarsi. Mi godo un’ora di riposo, poi si ricomincia. Ma come, dura così poco l’effetto? Eh, signora, cosa credeva!
Già, cosa credevo?
Forse mi aspettavo meno paura, un dolore naturale, invece così stordisce come un gancio ben assestato, il cervello si blocca, involve per cercare riparo in sé stesso e non sai più quanto tempo è trascorso, né dove sei. Dopo nove ore di contrazioni ad intensità costante e insopportabile, sono dilatata finalmente e mi portano in sala parto. Non ho più forze, non collaboro e si lamentano, non spingo e sbuffano, mi rimproverano, ma non fingo, le spinte non le percepisco proprio. Invece mi sento sbagliata, questo sì, un’inetta: partoriscono tutte e guarda, io non ci riesco.
Spinga su, forza! Respiri, spinga forte! Niente, non esce, preparatevi alla manovra di Kristeller, passami la ventosa. Parlano fra di loro come se fossi una bambola di gomma.
All’improvviso il ginecologo mi sale sulla pancia e spinge, lo prendo a pugni.
«Stia ferma! È impazzita?»
La bambina è in sofferenza fetale, dicono. Lascio che l’energumeno mi faccia schizzare gli occhi fuori dalle orbite per la pressione. Io urlo, Fabio piange.
Giada nasce.
È finita, penso. Ora siamo io e te, creatura mia, dono tanto sofferto. La mia prima figlia guarda come sei bella! Conto le tue dita minuscole, ci sono tutte, persino le unghie, perfette nella loro infinitesima grandezza. Accarezzo il ciuffo sparuto di capelli, sussurro che siamo state brave. Finalmente è passato tutto, non mi sentirò più incompresa, derisa persino, e rimproverata, di cosa bene non ho capito, ma so che è stato ingiusto.
Mi sbaglio, invece.
La vacca deve dare latte e dalla nascita in poi, in reparto si occupano esclusivamente che tu comprenda l’importanza dell’Allattamento Naturale A Richiesta, che significa ogni volta che la creatura urla. Ti istruiscono quanto basta a dimetterti in due giorni, non un’ora di più, con il tuo nuovo esserino a cui badare. Da sola, ça va sans dire.
Il pediatra convoca le neo-mamme in congedo: «Non perdete tempo a pesare il bambino né a preoccuparvi di altro, attaccatelo al seno a richiesta e basta. Qualsiasi valutazione la faremo solo dopo sette giorni dalle dimissioni». Provo a dire che la mia bambina fa fatica ad attaccarsi al seno: mi viene risposto che devo insistere, la Natura farà il resto. E io eseguo.
Giada piange di un pianto flebile. Dorme tantissimo e i pannolini sono quasi sempre asciutti man mano che i giorni passano, li appoggio alla guancia per sentire meglio se ci sono tracce di umidità, ma niente, profumano di bimbo e basta. Ne parlo a mia madre e lei risponde che se avesse fame piangerebbe di più; le amiche invece mi invidiano, loro non hanno dormito per mesi. I miei capezzoli sono enormi e le mammelle gonfie, con un reticolo di vene blu. La attacco al seno e dopo pochi minuti scivola via, la bocca semischiusa. È così bella e così brava la mia bambina!
Al controllo del settimo giorno, è disidratata e sottopeso.
Ma signora non si è accorta, non l’ha pesata? Mi avete detto di non farlo per niente al mondo.
Dove cazzo è la Natura quando serve?
L’ostetrica mi accompagna in una stanza dove mi munge letteralmente il latte dal seno: per quanto animata da intenzioni sincere, trovo orribile quello che fa. L’umiliazione e la fatica fruttano circa una decina di grammi di latte che Giada beve in un sorso.
«Non smetta di allattare, insista, la bambina è pigra» mi congeda il dottore.
Non smetto.
Passa un giorno e sono di nuovo in reparto con la febbre a trentanove per la mastite: ho un seno normale e l’altro viola ed enorme. Dal lato del seno buono, la camicia si inzuppa di latte.
«Ma lei il latte ce l’ha, allora! Perché non vuole allattare la bambina?» mi rimprovera il medesimo dottore.
Abbasso la testa nel tentativo di nascondere i goccioloni che scorrono lungo il naso. Rispondo che ho fatto tutto il possibile, ma Giada non si attacca; lui insiste perché firmi un documento dove mi assumo la Piena Responsabilità della Rinuncia all’Allattamento Naturale.
A casa non so quanto piango. Guardo le mie forme sfatte allo specchio e mi sembra uno sforzo inutile quello di aver fatto crescere una creatura dentro di me, se non sono neppure capace di nutrirla: la pelle cadente sulla pancia vuota, i seni gonfi e dolenti, le occhiaie e i capelli disordinati. Sono una madre indegna. Un contenitore vuoto e difettoso, congeniato per uno scopo che non sono capace di assolvere.
Poi suona il telefono, è l’ostetrica che vuole sapere come stiamo. Scambiamo poche parole, non riesco a trattenere il pianto, è come se tracimasse la tristezza da un pozzo profondo. Le parlo come fosse l’amica più cara, le dico che mi vergogno, che Giada non se la merita una madre così.
«Non dica sciocchezze!» reagisce. «Quello stronzo che l’ha visitata oggi è solo uno dei tanti con cui mi tocca lavorare ogni giorno. Non lo stia ad ascoltare… cosa vuole che ne sappia un uomo di cosa significa veramente la maternità?»
Ascolto in silenzio tirando su col naso. Mi dice che la presunta gioia della maternità è solo uno stereotipo, la felicità della nascita è una pressione sociale. Siamo tutte diverse e reagiamo in modo differente.
Piagnucolo che mia madre mi ha allattato fino a quindici mesi e io non sono stata capace di farlo neppure per quindici giorni.
«Fanculo l’allattamento al seno!» risponde, «Non esistono donne perfette e allattare non la renderà tale.»
Dice che esiste sempre uno scostamento della realtà dall’ideale che ci si costruisce sulla maternità, di accettarlo e, soprattutto, di scegliere sempre la strada più facile per me e la bambina.
Giada si è svegliata. L’acqua è già in temperatura nello scalda biberon, verso il latte in polvere e agito forte la bottiglia, avvito la tettarella e mi accomodo in poltrona. Giada spalanca la bocca e inizia a ciucciare, piantando gli occhi nei miei.
Marzo 2024